Italia e Giappone: come si cresce tra due culture
Di Ester Di Bona – Nata da madre italiana e padre giapponese, E. è cresciuta in Italia, a Palermo, vantando l’educazione di entrambe le culture. Vivendo in prima persona entrambi i contesti, la nostra intervistata mette a confronto le due nazioni e le rispettive società, facendo luce su molti punti che in Occidente vengono spesso ignorati.
Come si sono conosciuti i tuoi genitori?
«I miei si sono conosciuti nella palestra dove mio padre insegnava karate; inizialmente mia madre doveva trasferirsi in Giappone con lui, ma data la situazione e l’attaccamento tipico della nostra cultura alla famiglia, è stato mio padre a trasferirsi.
In Giappone c’è una mentalità diversa, sin da piccoli si è abituati a staccarsi dalla famiglia, ad essere indipendenti. Per esempio i bambini vanno all’asilo da soli, cosa che qui, in italia, non potrebbe mai accadere. Mio padre sotto questo punto di vista si era “italianizzato” un po’: mi accompagnava regolarmente a scuola tutte le mattine e mi viziava tantissimo.
Mi raccontava dei suoi allenamenti e delle sue gare giovanili, e con un po’ di amarezza e al contempo fierezza mi confessava che sua madre non aveva mai assistito a nessun incontro. Ne andava fiero perché ciò lo rendeva uomo, indipendente dalla famiglia, ma sono sicura che gli avrebbe fatto piacere vedere sua madre lì. Lui veniva sempre a vedere i miei saggi di danza e credo rimarcasse spesso questa differenza, tra sé e sua madre, per farmi capire che teneva davvero tanto a me».
La religione non è mai stata un ostacolo per i tuoi genitori?
«Si sono sposati “tre volte”: al comune, in chiesa e in Giappone. Mio padre, scherzando, si vantava di aver avuto tre matrimoni alle spalle. Non litigavano mai. Mio padre, da shintoista, ha acconsentito a farmi battezzare e a ricevere il sacramento della comunione. Ha sempre rispettato il Cristianesimo e le altre religioni, tuttavia ha criticato spesso i cristiani e l’ipocrisia di molti di loro».
Come hai vissuto questa differenza culturale durante la tua formazione educativa? La fortuna di aver avuto una educazione bipartita, crescendo, cosa ti ha dato?
«Sono cresciuta in un ambiente in cui generalmente non uscivo di casa, molte esperienze non le ho vissute perché “ero ancora troppo piccola” e anche il semplice andare a casa delle amiche (come delle mie cugine) era una cosa da grandi. Nella società contemporanea i ragazzi sono più liberi, ma nonostante tutto continuerei a volere un’educazione di quello stampo altre mille volte.
Sin da piccola, sono sempre stata abituata da mio padre ad essere forte, a non mostrare le mie debolezze, a non lamentarmi. Se venivo rimproverata da lui, correvo da mia madre perché era lei quella più comprensiva dei due. Ricordo che lui mi ha sempre ripetuto che quando sarebbe morto, io non avrei dovuto piangere per nessun motivo. Se oggi sono la persona che sono, lo devo al 70% a mio padre. Il mio lato più sensibile e “dolce”, quello che mi rende così attaccata alla mia famiglia, invece, lo devo principalmente a mia madre.
Io e mio padre litigavamo molto. Da donna tendevo a scontrarmi e mettermi al suo pari, cosa che in Giappone non è ben vista. Una volta, avevo 16 anni circa, durante una discussione molto accesa avevo alzato leggermente i toni. Non mi sono mai permessa di insultarlo anche perché avevo una sorta di timore e rispetto nei suoi confronti, e quella volta mi sono permessa di sostenere il suo sguardo. È stata la cosa più difficile che abbia mai fatto nella mia vita, e lui mi disse «Questo sguardo: mi piace. Stronza». È stata una offesa che è valsa come un grandissimo complimento: sono riuscita a sostenerlo ed essere “stronza” quanto lui».
È stata l’occidentalità a farti rispondere?
«Sì, sicuramente ha inciso molto, ma anche lo spirito combattivo tramandato da mio padre. Non era più importante se fossi donna o uomo, in quel momento mi sono sentita esattamente come lui. Nell’immaginario giapponese la donna deve restare al suo posto. È il maschio che deve combattere, che deve lavorare per sostenere la famiglia. C’è un grandissimo senso dell’onore e soprattutto del lavoro in Giappone, se non lavori non sei degno di essere uomo perché non puoi sostenere la tua famiglia. Oggi la donna sì, lavora, ma è l’uomo che secondo loro deve essere la colonna portante del nucleo familiare».
Tuo padre quando lavorava aveva un approccio più giapponese o italiano?
«Giapponese. Non si è mai preso una vacanza, e durante le festività se volevamo festeggiare in famiglia dovevamo andare a trovarlo al locale dove lavorava. Questo senso del lavoro non si è mai smorzato nonostante fosse in Italia, che non brilla certamente per il dinamismo dei suoi lavoratori».
In Giappone c’è un alto tasso di suicidi, dovuto principalmente al lavoro. È semplice stacanovismo o è realmente incentrato su dei valori morali, sul bene della famiglia? C’è qualcosa di distorto nella visione occidentale dell’oriente oppure no?
«Una mia amica si è stabilita in Giappone, laureata in lingue ed attualmente insegnante all’università, mi ha detto che lì non ha neanche il tempo di stare con la sua famiglia, perché è totalmente concentrata sul lavoro. Per un italiano che va a vivere lì è certamente tutto un altro mondo».
Tu come la vivresti una situazione simile?
«Per me che sono abituata alle comodità di questo Paese, dovrei cercare di abituarmi. Nell’immaginario comune giapponese, se vedi che qualcuno attorno a te sta ancora lavorando, ti senti costretto a rimanere per non essere il primo a tornare a casa, perché in quel modo distruggeresti la morale della compagnia in cui lavori, pensi “come puoi permetterti di andartene prima che gli altri lo facciano?”. Ovviamente le persone non sono tutte uguali, non si può sperare di omologarle e renderle capaci di sostenere ritmi disumani, di essere degli automi. Può, quindi, capitare la persona più fragile che viene portata all’esasperazione da questo stile di vita, un fenomeno chiamato karōshi, morte da troppo lavoro».
Giappone e Italia: tu dove vorresti lavorare?
«Ci ho pensato spesso, non sono una giapponese modello e calata in quel contesto mi verrebbe molto difficile. È sempre stato il mio sogno nel cassetto vivere lì, ricordo fosse un paese estremamente affascinante. Lavorando qui avrei tutti i comfort (o quasi), ed anche l’ultimo tirocinio che ho fatto aveva orari molto flessibili. Qui, se lavori in regola, hai un sacco di tutele e sei preservato».
Di questa impostazione, della cultura del lavoro, quanto hai ricevuto?
«Mio padre mi ha sempre detto «iscriviti all’università, poi quello che devi fare fai, ma la laurea la devi avere perché è una presentazione differente». Però capitava che mi dicesse «se non vuoi studiare, vieni a lavorare da me». Non avrebbe mai permesso che restassi con le mani in mano, invece vedo tantissimi ragazzi che stanno a casa. In Giappone neanche esiste il termine mammone: lì se ne vanno negli appartamenti da soli e c’è anche un alto tasso di studenti lavoratori. Dal liceo vanno a lavorare anche come semplici camerieri per sostenere i propri studi. Qui le tasse universitarie le pagano in alternativa i tuoi genitori, lì o ti autofinanzi o vai a lavorare.
Inoltre non importa cosa fai, un lavoro non è meno importante di un altro: se fai l’operaio non vali meno di un medico perché il lavoro ha una valenza al di là dello status sociale, non c’è un ruolo più dignitoso. Bisogna portare rispetto anche allo spazzino. E chi fa il lavoro, lo fa come si deve. Ci sono sempre le pecore nere, il Giappone non è perfetto e c’è sempre chi il proprio lavoro lo svolge svogliatamente, ma non è comune come qui. In Italia esci da casa e butti la carta per terra: significa che non ti preoccupi della tua città».
Sono molto civili in Giappone, amano il proprio paese, sono molto patriottici. Qui in Italia si è perso questo spirito? Anche vedendo la differenza tra i pareri dei tuoi genitori dei loro rispettivi paesi.
«Mia madre ha una visione dell’Italia catastrofica. Mio padre si vantava molto del Giappone. Diceva anche che la Sicilia è un posto bellissimo ed è stata data in pasto ai siciliani, che la stanno rovinando. In tutti questi anni non mi sono mai spiegata perché i palermitani siano così menefreghisti nei confronti della loro terra, come si sia arrivati a questo punto. Qui c’è una mentalità strafottente, priva di rispetto verso il prossimo e verso la propria terra. E si vede dalla sporcizia, dai monumenti imbrattati alle strutture abbandonate.
La cosa che manca qui è il rispetto. Forse se si rispettasse di più il lavoratore, la strada o il monumento anche la Sicilia (e perché no, anche l’Italia) tornerebbero a brillare, e non si avrebbe più paura di rivelare le proprie origini. Non si può pretendere che gli altri amino l’Italia se per primi la trattiamo con i piedi».
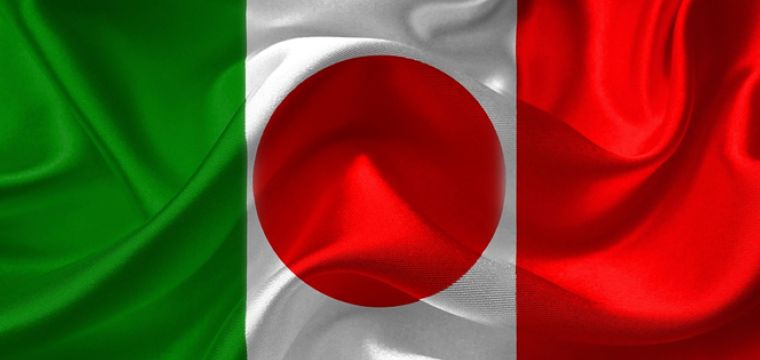
1 commento